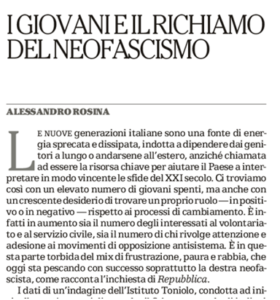
LE NUOVE generazioni italiane sono una fonte di energia sprecata e dissipata, indotta a dipendere dai genitori a lungo o andarsene all’estero, anziché chiamata ad essere la risorsa chiave per aiutare il Paese a interpretare in modo vincente le sfide del XXI secolo. Ci troviamo così con un elevato numero di giovani spenti, ma anche con un crescente desiderio di trovare un proprio ruolo — in positivo o in negativo — rispetto ai processi di cambiamento. È infatti in aumento sia il numero degli interessati al volontariato e al servizio civile, sia il numero di chi rivolge attenzione e adesione ai movimenti di opposizione antisistema. È in questa parte torbida del mix di frustrazione, paura e rabbia, che oggi sta pescando con successo soprattutto la destra neofascista, come racconta l’inchiesta di Repubblica.
I dati di un’indagine dell’Istituto Toniolo, condotta ad inizio di quest’anno, ci dicono che il 6,1 per cento degli italiani tra i 20 e i 34 anni si colloca alla destra più estrema. Un dato che sale quasi a uno su dieci se si considerano anche coloro che si sentono molto vicini a tale area politica. Il bacino di pesca dei movimenti che mescolano xenofobia, difesa dei valori della patria e conservazione della tradizione, può però risultare ancora più ampio rispetto a quanto rivelano questi numeri, per due motivi.
Il primo deriva dal fatto che più che le categorie “destra” e “sinistra” il discrimine nell’orientare le preferenze politiche dei giovani è soprattutto quello sull’asse apertura-chiusura. La percentuale di chi è schierato decisamente dal lato della chiusura risulta più alta rispetto a chi si identifica con la destra estrema. L’indagine ci dice che il 12,3% degli intervistati considera chi arriva da altri paesi esclusivamente come minaccia per la nostra società; il 20,1 per cento ritiene sia assoluta priorità della politica la protezione dei nostri valori morali e religiosi tradizionali.
Il secondo motivo è il fatto che l’indagine riguarda ventenni e trentenni. Meno chiaro è l’orientamento al voto di chi deve ancora compiere 18 anni o li ha compiuti da poco. Ma è proprio questa la fase in cui è più forte la voglia di provare a mettersi in gioco, di far parte di qualcosa di nuovo che migliori o si contrapponga all’esistente. Più si tarda a offrire un’offerta credibile e convincente di espressione positiva di tale desiderio, più aumenteranno i ragazzi che faranno la loro prima esperienza di partecipazione politica con movimenti estremisti.







