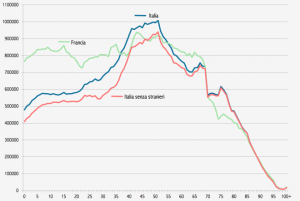L’Italia si svuota dal basso e da sud. La popolazione italiana è in riduzione come conseguenza di una persistente denatalità. Un fenomeno che prima ha colpito il Nord e ora sempre più il Sud. La questione vera non è tanto l’essere di meno, ma gli squilibri demografici che ne derivano. Le generazioni quantitativamente più consistenti, nate nei primi decenni del secondo dopoguerra, si stanno spostando sempre più in età da pensione, mentre nelle classi scolastiche italiane entrano sempre meno bambini.
Ancora nel 2000, il tasso di fecondità totale, che corrisponde al numero medio di figli per donna in età riproduttiva, era pari a 1,35 nel Mezzogiorno e a 1,2 nel Nord. Le aree con fecondità più elevata erano la Campania e la provincia di Bolzano con 1,48 figli per donna. La provincia di Bolzano negli anni successivi ha visto leggermente crescere il suo valore e assestarsi attorno a 1,6. Di conseguenza il numero di nascite in tale area rimasto costante, cosicché i bambini che entrano nel sistema scolastico ogni anno oscillano attorno ai 5500. La Campania è stata invece una delle regioni che maggiormente hanno visto ridursi la natalità, perdendo completamente il vantaggio rispetto alla media nazionale. Questa accelerata convergenza al ribasso ha prodotto un forte indebolimento della base demografica della regione. La generazione di chi ha oggi 25 anni presenta una numerosità ancora abbondantemente sopra le 70 mila persone, si scende però a poco più di 60 mila per chi ha 10 anni e a meno di 50 mila per i nuovi nati. Un riscontro è, appunto, l’avvitamento verso il basso della popolazione studentesca, monitorato ormai da vari anni dalla Fondazione Agnelli.
Quali sono le implicazioni di questo processo e come si può rispondere? La prima cosa da fare è evitare che gli squilibri prodotti si allarghino ulteriormente, ovvero cercare di fermare la riduzione della natalità e ridare forza alle componenti di vitalità del territorio. Sono soprattutto due i punti nodali su cui agire, il primo è quello della relazione tra lavoro e autonomia dei giovani, il secondo è l’armonizzazione tra lavoro e famiglia nei percorsi femminili (e in corrispondenza anche maschili). Riguardo al primo nodo, la difficoltà dei giovani nel consolidare il percorso lavorativo porta ad aumentare la dipendenza dalla famiglia di origine. Come mostrano i dati del “Rapporto giovani” dell’Istituto Toniolo, la situazione di incertezza porta a posticipare la formazione di una propria famiglia, condizionandola all’aver terminato gli studi, all’aver trovato un lavoro abbastanza stabile e con uno stipendio che consenta uno standard di vita dignitoso, alla prospettiva di poter acquistare casa. La difficoltà a realizzare tali tappe rende i giovani ipercauti nelle scelte verso il futuro.
Se il primo nodo pota ad un rinvio continuo del primo figlio, il secondo nodo frena la possibilità di andar oltre. Se, infatti, dopo la prima nascita ci si trova in difficoltà a rendere compatibili i tempi familiari con quelli lavorativi, per carenza di servizi per l’infanzia e per carenza di collaborazione del padre, difficilmente ci si sente incentivati ad averne un secondo. I dati comparativi europei mostrano che dove più solidi e accessibili sono gli strumenti di conciliazione tra lavoro e famiglia, chi ha lavoro sceglie maggiormente di avere un figlio e chi ha un figlio maggiormente si offre nel mercato del lavoro.
Ma c’è un altro aspetto da considerare. Con la ripresa della natalità si può limitare l’ampliamento degli squilibri, ma quelli oramai prodotti dalla denatalità passata sono destinati a rimanere. Come affrontarli? La risposta principale è compensare la riduzione quantitativa delle generazioni nate negli ultimi quindici anni con un solido piano di investimento qualitativo su di essi, a partire dalla formazione. Come suggerisce la stessa Fondazione Agnelli, pensare che, dato che gli alunni sono di meno, si possa risparmiare su risorse, spazi e insegnanti, sarebbe l’implicita conferma di aver accettato un declino, non solo demografico, senza prospettive.