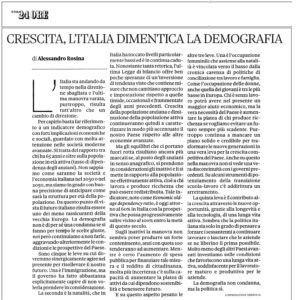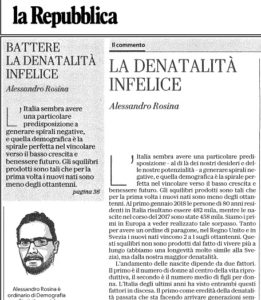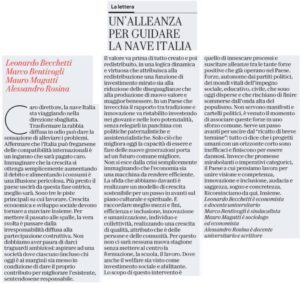Se l’Italia economica è in recessione tecnica, l’Italia demografica è in recessione cronica. Il segno meno sulla popolazione italiana persiste dal 2015, come certificato dagli ultimi dati Istat. Abbiamo buone ragioni per temere di trovarci nell’anticamera di una lunga fase di declino destinata a caratterizzare il resto del secolo.
Non siamo i soli, ma siamo più soli degli altri. In un’Europa che vede diminuire il suo peso nel mondo, l’Italia mostra di anticipare e accentuare tale tendenza: nessun altro grande paese europeo si trova in sistematica diminuzione. La Spagna ha superato i 46 milioni di abitanti nel 2008, ha subito una frenata negli anni acuti della crisi, ma ha poi ripreso a salire avvicinandosi ai 47 milioni. Più solida la crescita della Germania che ha guadagnato oltre un milione e mezzo di residenti dal 2015. Simile la situazione del Regno Unito. A metà tra Germania e Spagna si colloca invece la Francia.
L’Italia, che era nella top 10 dei paesi più popolati al mondo a metà del secolo scorso, ora non è più nemmeno nella top 20 ed è destinata a scendere sempre più in basso nei prossimi decenni. Il nostro peso relativo sul pianeta è sceso sotto lo 0,8 percento. Cina e India assieme superano il 35 percento. E’ evidente, da questi numeri, come avere ruolo in un’Europa che ha un suo ruolo nel mondo sia l’unico modo per non diventare del tutto marginali.
I dati demografici ci dicono però che manteniamo il non invidiabile podio mondiale dei paesi con più intenso invecchiamento della popolazione. Anche su questo punto anticipiamo e accentuiamo le tendenze: nel continente più vecchio l’Italia è il paese con più alta percentuale di anziani. Nel mondo l’incidenza di chi ha 65 anni e oltre è sotto il 10 percento. Tra i grandi paesi europei Francia, Spagna e Regno Unito si mantengono ancora sotto il 20 percento. La Germania arriva a superare il 21 percento. I recenti dati Istat posizionano il nostro paese al 22,8 percento.
In un editoriale redazionale pubblicato su Neodemos, la rivista online dei demografi, l’Italia è ritratta come “un sottomarino che sembra aver perso la spinta per riemergere”, bloccato sul fondo da una “questione demografica” di cui c’è bassa consapevolezza e scarsa capacità di cura.
La popolazione è come un organismo che per crescere ha bisogno di essere alimentato. A sostenerla sono le nascite e gli arrivi dall’estero. L’immigrazione è stata rilevante negli anni precedenti la crisi, ma è scoraggiata dalla bassa crescita economica ed è disincentivata oggi dalle forze politicamente maggioritarie nel paese. In compenso non viene offerto nessun solido e convincente rafforzamento dell’altra fonte della crescita demografica, ovvero la natalità. Tant’è vero che il numero medio di figli per donna rimane inchiodato ai livelli più bassi in Europa. Nelle scelte di vita dei cittadini italiani la ripresa post crisi non si è (ancora) vista. La fecondità anziché diminuire dopo la lunga congiuntura negativa e poi risalire, sembra essersi solo riposizionata su livelli più bassi. Evidentemente non appare ancora così solido il miglioramento delle condizioni economiche dei giovani e delle famiglie, o non ancora ben ancorato a politiche credibili di sviluppo in grado di rilanciare la fiducia del paese verso il proprio futuro. Ecco allora che le nascite del 2018 risultano ridotte del 22 percento rispetto al dato del 2008.
Oltre ad aver reso deboli le entrate abbiamo nel contempo rafforzato le uscite. Il quadro di incertezza e basse prospettive non solo tiene bassa la fecondità ma incentiva anche la scelta di cercare migliori opportunità altrove. Le emigrazioni nel 2018 sono salite a 160 mila. Fatto che contribuisce ulteriormente a far diminuire la popolazione e aumentare il peso della componente anziana.
Più che il declino della popolazione preoccupa la struttura sempre più indebolita sul versante delle nuove generazioni, sia per i vincoli che pone allo sviluppo economico e alla sostenibilità sociale, sia perché denatalità ed espatri sono spie sensibili delle difficoltà a costruire un futuro solido per sé e per chi verrà dopo. Se rinunciamo a questo rimane solo la rassegnazione e l’assuefazione a questi e a peggiori dati.