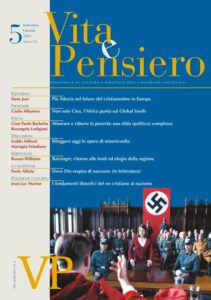Sappiamo una sola cosa certa del futuro, che è diverso dal presente. Per star meglio domani rispetto ad oggi è necessario allora operare in modo che tale diversità sia sostenibile e, possibilmente, si integri positivamente con i meccanismi che producono benessere collettivo. Dell’Italia del 2050 sappiamo che sarà strutturalmente diversa da quella di oggi, senz’altro con più popolazione nelle età considerate tradizionalmente anziane e meno persone in età lavorativa.
L’indicatore che misura il rapporto tra tali due categorie di popolazione è uno di quelli guardati con più attenzione dalle economie avanzate. Se tale rapporto aumenta significa che nella bilancia demografica il peso si sposta dal piatto dell’età in cui si produce ricchezza a quello dell’età in cui si assorbono risorse pubbliche per spesa previdenziale e sanitaria. Quando, nei primi decenni del secondo dopoguerra, l’Italia cresceva in modo solido – al pari o più del resto del mondo sviluppato – il primo piatto aveva un peso cinque volte maggiore del secondo. Nel 2050 ci troveremo con un rapporto 4 a 3. Si tratta di uno dei valori più squilibrati in Europa, non tanto a causa dei livelli di longevità italiani, non molto diversi da quelli francesi o scandinavi, ma per la nostra persistente bassa natalità. L’impatto sull’economia e sulla sostenibilità della spesa sociale di tale squilibrio demografico è però accentuato dai criteri di accesso alla pensione e dal numero di effettivi lavoratori tra le persone in età attiva.
Se allora, come indica il recente rapporto Ocse “Working Better with Age”, si mette ha propriamente un lavoro sul primo piatto e nel secondo chi è inattivo o in pensione, il rapporto rischia di diventare di 1 a 1. Si andrebbe, così, a configurare uno degli scenari peggiori tra i Paesi membri dell’Unione europea. L’Italia, che già oggi cresce meno rispetto al resto delle economie avanzate e ha una spesa pubblica tra le più squilibrate a favore delle generazioni più anziane, si troverebbe ad inasprire le sue difficoltà. In questo scenario andrebbe ad indebolirsi la crescita competitiva del paese, con conseguente riduzione dei margini per contenere il debito pubblico, per finanziare formazione, ricerca e sviluppo, politiche familiari. Le disuguaglianze sociali diventerebbero ancora più acute, interagendo con quelle generazionali, di genere e territoriali. Aumenterebbero ulteriormente i già particolarmente elevati livelli di povertà delle famiglie monoreddito con figli minori. Con meno investimenti e opportunità per le nuove generazioni ci si può inoltre aspettare una intensificazione del flusso di uscita dei giovani più dinamici e qualificati verso l’estero. La crescita della popolazione anziana, in carenza di politiche di conciliazione e di servizi per i non autosufficienti, porterebbe inoltre ad accentuare il carico di cura sulle famiglie, comprimendo, in particolare, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
La conseguenza sarebbe, insomma, un ampliamento delle distanze dagli altri paesi avanzati, ma anche tra le varie aree e le diverse categorie sociali all’interno del nostro paese. Se negli ultimi trent’anni i livelli del debito pubblico, delle diseguaglianze sociali, della dipendenza passiva dei giovani dalla famiglia di origine, sono aumentati, l’allargamento degli squilibri demografici va nella direzione di renderli ancora meno sostenibili, rendendo l’Italia sempre più marginale nei processi di produzione di benessere nel resto di questo secolo.
Si tratta di un destino ineluttabile? La risposta è no, ma lo diventa implacabilmente se non cambiamo, ovvero se non ci mettiamo a fare nei prossimi trent’anni quello che nei trent’anni scorsi non siamo riusciti a fare, in un contesto che nel frattempo è peggiorato. Quello che serve per scongiurare lo scenario peggiore delineato dall’Ocse e che ci condannerebbe al declino infelice, è dar peso al piatto della componente di popolazione che produce ricchezza. In tale direzione va una redistribuzione delle risorse del Paese non assistenzialista o clientelare, ma a favore delle voci che al contempo consentono di ridurre le diseguaglianze e promuovere un contributo attivo e qualificato alla crescita. L’Italia presenta attualmente tra i più bassi tassi di occupazione giovanile e femminile in Europa, ancora più bassi nel Sud e nelle categorie sociali con basse risorse socioculturali. Questo significa che politiche efficaci rivolte a queste aree e a queste categorie sono quelle in grado di dare la maggior spinta al riequilibrio del paese. Da realizzare in coerenza con le sfide che l’innovazione tecnologica pone, con la necessità di mettere positivamente assieme scelte di vita e professionali, favorendo la collaborazione tra competenze, facendo in modo che le diversità (di età, genere, provenienza) portino valore aggiunto alla crescita comune anziché alimentare diseguaglianze corrosive. Se c’è una strada che porta verso un 2050 non peggiore (forse anche migliore) del presente, va senz’altro in questa direzione.